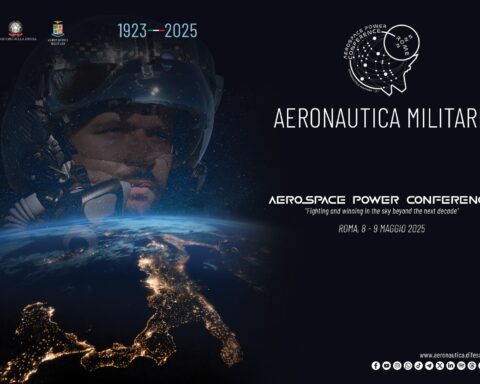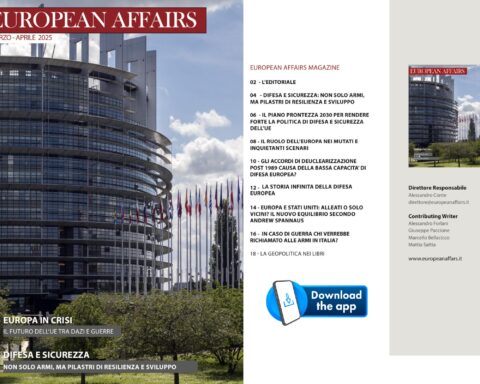”Questa mattina alle 7.35 il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre”, lo ha annunciato il cardinale Kevin Farrell nella dichiarazione pubblicata dal Vaticano sul suo canale Telegram. Dalla “fine del mondo” al centro della cristianità: così si è presentato Jorge Mario Bergoglio, argentino di origini italiane, quando il 13 marzo 2013 è stato eletto Pontefice. Primo Papa gesuita, primo proveniente dal continente americano, primo a scegliere il nome di Francesco, ispirandosi al Santo di Assisi. Un nome che è diventato da subito il manifesto spirituale e programmatico di un pontificato rivoluzionario nella sua semplicità.
Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 da una famiglia piemontese emigrata in Argentina, Francesco ha vissuto un’esistenza segnata da esperienze forti fin dalla giovinezza: una grave malattia polmonare lo ha avvicinato alla vocazione religiosa, portandolo a entrare nei gesuiti e a laurearsi in Filosofia. Ordinato sacerdote nel 1969, ha scalato lentamente ma con costanza la gerarchia ecclesiastica fino a divenire, nel 2001, cardinale per volontà di Giovanni Paolo II.
Già nel Conclave del 2005 era tra i favoriti, ma è nel 2013, dopo la storica rinuncia di Benedetto XVI, che il mondo lo scopre nuovo Papa. Lo fa nel segno della sobrietà, rinunciando all’appartamento pontificio e scegliendo di vivere alla Domus Santa Marta. Lo fa nel segno della vicinanza, con il celebre “buonasera” rivolto alla folla in Piazza San Pietro. Lo fa nel segno della riforma, avviando un lungo cammino di cambiamento nella Curia romana.
Incontri e simboli: il Papa del dialogo
I suoi gesti hanno spesso parlato più delle sue parole: l’abbraccio con Benedetto XVI, la preghiera con i leader di Israele e Palestina nei Giardini Vaticani, la storica firma del Documento sulla Fratellanza Umana ad Abu Dhabi, fino all’incontro con il patriarca ortodosso Kirill all’Avana. Il suo pontificato ha cercato ponti dove prima c’erano muri, nel segno dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso.
E proprio in quest’ottica vanno lette le sue encicliche più significative: Laudato Si’, appello appassionato per una “ecologia integrale” che rispetti la Terra e i più deboli, e Fratelli Tutti, inno alla fraternità universale nato anche dall’esperienza drammatica della pandemia. Senza dimenticare Evangelii Gaudium, in cui invoca una “conversione missionaria” della Chiesa, più vicina alle periferie del mondo.
Papa delle periferie e delle parole semplici
Francesco ha scelto di guardare il mondo dai margini: dal primo viaggio a Lampedusa alle visite a Lesbo, dalla messa a Bangui in Centrafrica all’incontro con i migranti nei campi profughi. Non ha mai nascosto le piaghe dell’umanità, facendosene carico con la forza della compassione evangelica.
Ha parlato a capi di Stato e a rifugiati, a fedeli e a non credenti, ma le sue parole più potenti sono rimaste quelle pronunciate con semplicità: “Buongiorno”, “Buon pranzo”, “Non dimenticate di pregare per me”. Parole che, nel silenzio surreale della pandemia, sotto la pioggia in una piazza San Pietro vuota, sono risuonate ancora più forti.
Un’eredità viva e aperta
A oltre dodici anni dall’inizio del suo pontificato, Papa Francesco continua a segnare la storia della Chiesa con passi che uniscono radicalità evangelica e umanità concreta. Dalla riforma delle finanze vaticane all’attenzione per le crisi ambientali e sociali globali, dalla sinodalità come metodo di governo all’impegno per la pace e la giustizia, Francesco rimane un punto di riferimento globale. La sua è una Chiesa in uscita, fatta non di potere ma di servizio, capace di parlare al cuore del mondo. Ed è forse proprio questo il miracolo più grande di un Papa “venuto dalla fine del mondo”: aver riportato la Chiesa al cuore delle persone.