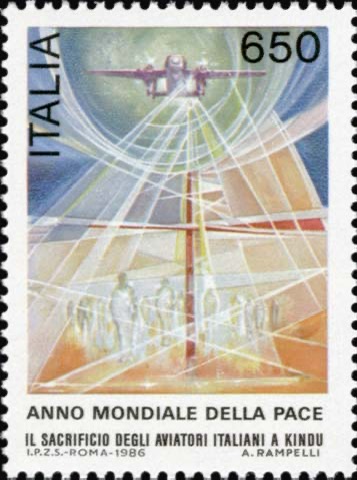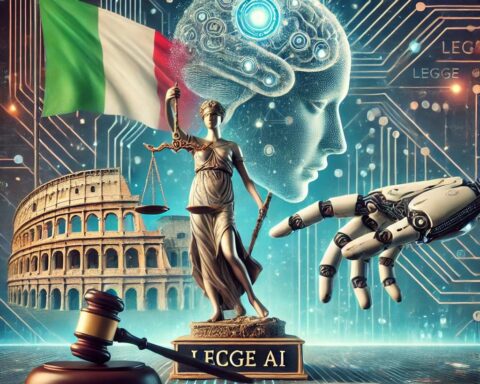Il cambiamento climatico è ormai diventato un argomento molto diffuso, grazie anche ai dibattiti accademici e scientifici che stanno coinvolgendo la società. Innanzitutto, conviene specificarlo, i cambiamenti climatici non sono una novità: quello che spaventa scienziati e politici è la proporzione che questi hanno assunto negli ultimi decenni. Alcuni studi affermano che negli ultimi 30 anni la temperatura è cresciuta ad un ritmo maggiore di quanto non si sia verificato negli ultimi 1400 anni. I ricercatori sono d’accordo nel definire il clima come un acceleratore di instabilità ed un catalizzatore di effetti o, meglio ancora, un ingrediente in grado di esacerbare tensioni ed aumentare il rischio di conflitti. Agendo direttamente sui bisogni fondamentali esso è in grado di stressare società, economie, infrastrutture.
Possiamo dividere i rischi partendo da una prima importante categorizzazione. I rischi diretti, quelli cioè derivanti da fenomeni naturali sempre più frequenti come tempeste, precipitazioni consistenti ecc, che hanno un impatto diretto ed immediato sull’ambiente e sulle società; i rischi indiretti, in grado di causare effetti di natura collaterale anche molto gravi, la cui pericolosità deriva da un’osservazione fondamentale: più le nostre vite e le nostre abitudini sono dipendenti dalla tecnologia, dalle infrastrutture, da servizi di diverso genere per soddisfare i nostri più svariati bisogni, più cresce la preoccupazione che questo genere di eventi sia in grado di minacciare la nostra sicurezza, la qualità della nostra vita.
L’interconnessione dei commerci, della finanza, del trasporto di merci, persone, informazioni è senza dubbio l’elemento caratterizzante questo secolo e nel prossimo futuro lo sarà in maniera sempre più diffusa e pervasiva. Di conseguenza possiamo affermare che eventi climatici naturali locali o regionali, sono in grado di avere effetti importanti su larga scala. Il punto su cui dovrebbero convergere le politiche e gli sforzi del settore pubblico e privato è uno e molto importante: bisogna che si decida quanta percentuale di rischio siamo disposti a considerare. Tenendo presente che inevitabilmente fenomeni climatici straordinari impatteranno in maniera seria su economie e società e considerando l’assenza di una zero risk policy bisogna agire in maniera differente nel breve, medio e lungo periodo, approntando le necessarie misure e precauzioni sulla base delle previsioni e soprattutto sul modello di vita che prospettiamo per le generazioni future. Questo genere di decisioni non possono essere più rimandate ad una data da destinarsi.
La conclusione più saggia è sicuramente quella che conduce ad un rafforzamento della cooperazione internazionale. Ci sono fenomeni che sicuramente non possono essere fermati, altri che possono essere misurati e quindi in parte affrontati con appropriate misure di sostenibilità ambientale, economica, sociale. Quello che prospettano le ricerche e le proiezioni degli analisti è un aumento dell’instabilità a livello nazionale ed internazionale, che va però sommata ai cambiamenti sociali ed economici e che rischia di mettere in pericolo (o quanto meno causare ulteriori tensioni e stress) le comunità che ne saranno interessate direttamente ed indirettamente. Un esempio fra tutti le migrazioni forzate a causa di carestie e siccità. In un mondo così interconnesso, in cui regioni distanti sono influenzate da cambiamenti di natura politica, disastri ambientali, politiche di tipo conservativo non sono assolutamente la strada corretta da intraprendere. Eppure gli esperti ritengono che siamo ancora in tempo per intraprendere misure in grado di ridare col tempo un assetto più equilibrato all’ecosistema.
Alcuni studi suggeriscono che anche nel caso di misure aggressive per fermare l’inquinamento, il nostro pianeta necessiterebbe decine e decine di anni per ritornare ad un proprio stato d’equilibrio: uno scenario sicuramente non rassicurante. Nel suo studio Degrees of risk – defining a risk management frameworkfor climate security Mabey afferma che alcune politiche di riequilibrio dovrebbero andare di pari passo con l’aumento della temperatura globale, precisando che gli scenari di mitigazione divergono fortemente sulla base dei diversi livelli di emissioni e che, date delle politiche di riduzione e contenimento delle emissioni che siano generalmente condivise ed adottate, le applicazioni devono divergere ed essere tarate sulla base delle necessità e possibilità dei singoli Paesi. C’è poi un collegamento interessante tra i dati di questi studi e l’elemento governance. A causa degli impatti che il clima avrà sulle società (l’innalzamento della temperatura ad esempio sarà in grado di far sentire i suoi effetti sull’agricoltura, sulla vivibilità di centri urbani ecc), il modo in cui i governi decideranno di intraprendere politiche responsabili sarà in parte in grado di determinare il loro grado di sopravvivenza, competizione o fallimento. La differenza tra politiche di mitigazione che avranno impatti positivi o negativi sulla società avrà il suo peso laddove i governi siano caratterizzati da deboli istituzioni. Sebbene il richiamo di Mabey di restare sotto la soglia dell’aumento di 2°C sia stato già superato, lo studioso propone tre differenti approcci al problema: obiettivi di mitigazione per un aumento di 2°C ( siamo in presenza in questo caso di un aumento gestibile) e politiche di resilienza sviluppate a partire da quadri nazionali indipendenti, egli considera la possibilità di un aumento ulteriore tra i 2°C ed i 4°C suggerendo di adottare strategie internazionali di gestione delle risorse e coordinare interventi umanitari. Il terzo e più estremo degli scenari (un innalzamento che arriva ai 7°C) non lascerebbe altro spazio se non quello di preparare piani di emergenza che siano in grado di far fronte a dei veri e propri disastri. E’ chiaro che queste sono previsioni basate su trend storici e calcoli di proiezione, ma quanto detto riguardo la teoria della mitigazione del rischio fornisce un utile spunto e strumento che può servire l’investigazione di quelle politiche che saranno sempre più comuni nel prossimo futuro e diverranno sicuramente un punto importante di discussione e frizione tra gli stati.